
di Leonardo Pinnelli
L’esperienza spirituale del monachesimo antico sottolineava in maniera forte la necessità del raggiungimento della hesychia, o preghiera pura, senza la quale non può esservi vera orazione. Gli antichi monaci hanno cercato di raggiungere l’obiettivo di questa preghiera pura, cioè la stabilità del proprio cuore di fronte a Dio. Essi cercarono non un “atto” continuo di preghiera, quanto piuttosto una disposizione costante, stabile a pregare. Padre Špidlík in un suo articolo riporta un esempio simpatico che aiuta a comprendere in cosa si esplichi questa “stabilità”: un musicista non deve pensare come e se suonare, ma , essendo egli stesso musicista, istintivamente sa suonare. Questo vale per ogni situazione: una mamma è una mamma anche se non deve ricordarselo, educa i figli e basta, questa è la sua disposizione continua: essere mamma. Questo discorso vale anche per la preghiera
Afferma padre Špidlík:
Dunque, avere la disposizione del cuore alla preghiera è molto più che pregare in momenti differenti. Significa essere disposti a pregare, quando è possibile. Gli autori spirituali dell’Oriente chiamavano ciò la “perfezione della preghiera”.
Un monaco rumeno, testimone vivente della tradizione esicasta, padre Teofil Paraian, è sulla stessa linea del padre Špidlík:
La preghiera incessante del cuore la possiamo raggiungere tramite la grazia di Dio nella misura dei nostri sforzi. Lo sforzo porta alla disposizione permanente e questa, a sua volta, rende possibile la preghiera continua. In realtà la preghiera incessante non va intesa come una semplice ripetizione continua di una formula di preghiera, ma piuttosto come uno stato di preghiera: la coscienza permanente della presenza di Dio, coscienza dalla quale scaturisce necessariamente la glorificazione di Dio.
A partire da quanto appena affermato possiamo sottolineare alcuni aspetti:
Afferma padre Špidlík:
Dunque, avere la disposizione del cuore alla preghiera è molto più che pregare in momenti differenti. Significa essere disposti a pregare, quando è possibile. Gli autori spirituali dell’Oriente chiamavano ciò la “perfezione della preghiera”.
Un monaco rumeno, testimone vivente della tradizione esicasta, padre Teofil Paraian, è sulla stessa linea del padre Špidlík:
La preghiera incessante del cuore la possiamo raggiungere tramite la grazia di Dio nella misura dei nostri sforzi. Lo sforzo porta alla disposizione permanente e questa, a sua volta, rende possibile la preghiera continua. In realtà la preghiera incessante non va intesa come una semplice ripetizione continua di una formula di preghiera, ma piuttosto come uno stato di preghiera: la coscienza permanente della presenza di Dio, coscienza dalla quale scaturisce necessariamente la glorificazione di Dio.
A partire da quanto appena affermato possiamo sottolineare alcuni aspetti:
- Si può raggiungere l’incessante preghiera del cuore tramite la grazia di Dio nella misura dei nostri sforzi;
- Tale sforzo porta alla disposizione permanente;
- Avere la disposizione del cuore alla preghiera è molto più che pregare in momenti differenti;
- Questa disposizione permanente rende possibile la preghiera continua e ciò significa essere disposti a pregare quando è possibile.
Ciò che appare importante è che per raggiungere la preghiera del cuore bisogna affrontare uno sforzo personale, una fatica del cuore, che però sia aperto alla grazia del Signore. Questa fatica è l’atteggiamento fondamentale del monaco che consiste nella continua lotta fra il mettere in pratica i comandi del Signore e il pentimento per il proprio peccato. Tale atteggiamento può efficacemente riassumersi nel sostantivo greco praxis. «Il termine praxis […] comprende tutto ciò che definiamo “pratiche” della vita cristiana, sia negative (purificazione dal peccato e dalle sue conseguenze), sia positive (l’esercizio delle virtù)».
Nella letteratura spirituale antica sovente viene sottolineata questa dimensione della vita ascetica: essa rappresenta un aspetto necessario che purifica il cuore del monaco e lo apre alla pratica della preghiera pura (contemplazione o theoria).
È dunque la praxis che eleva il monaco alla theoria, cioè ogni fatica, globalmente intesa, fisica, spirituale, morale, introduce l’uomo nel «regno dei cieli». Padre Špidlík propone alcune chiarificazioni di questo assioma generale della vita spirituale:
· La purificazione deve precedere l’illuminazione;
· Le virtù introducono alla conoscenza;
· La vita in Cristo conduce all’illuminazione;
· Dal visibile si giunge alla conoscenza dell’invisibile;
· L’uomo interno entra in relazione con Dio;
· La teologia del tempo e dell’eternità;
· L’unione diviene ascesi mistica;
Indipendentemente dall’interpretazione che si vuole preferire, rimane vero che l’opera del monaco è indirizzata al recupero della propria salute spirituale e all’acquisizione dell’unione con Dio, al raggiungimento di un cuore e di una mente puri e quindi della contemplazione.
Affinché l’uomo raggiunga la contemplazione e viva la preghiera pura, è necessario che la sua mente sia sgombra di ogni sorta di immagini e concetti e pensieri cattivi o di carattere spirituale, è indispensabile che essa sia pura. « La prima condizione della contemplazione è […] la purificazione dal peccato, la penitenza, perché lo Sposo non ama unirsi ad un’anima che gli è estranea».
Tutti gli autori sono concordi sulla necessità di estirpare ogni impurità dal cuore; non c’è invece concordanza su in che cosa consista concretamente questa purificazione: se sia purificazione della carne, dei sensi, dei pensieri cattivi, del peccato.
Afferma Evagrio Pontico che la preghiera non potrà essere pura se l’orante si lascia coinvolgere da faccende materiali e turbare da continue preoccupazioni. Preghiera, infatti, vuol dire rimozione dei pensieri.
Nella spiritualità monastica, generalmente il termine pensiero ha un’accezione del tutto negativa: è lo strumento attraverso il quale il nemico può entrare nel cuore dell’uomo e così indurlo al peccato. Non può pregare in maniera tranquilla colui che non ha acquisito l’arte di combattere i propri nemici spirituali.
Gli autori antichi insegnano la differenza tra «pensiero semplice» e «pensiero appassionato».
La mente umana, fatta ad immagine di quella divina, può pensare qualsiasi cosa; generalmente però quanto viene pensato è raro che risulti essere «puro», in quanto al pensiero si aggiunge la tendenza a desiderare qualcosa contro i comandi di Dio, ciò che i greci chiamano prospatheia. L’uomo spirituale dovrà distinguere il pensiero dalla sua passione. Doroteo di Gaza chiama questo pensiero passionale «volontà propria».
La tradizione monastica ha cercato di praticare questa purificazione della parte passionale dell’anima attraverso la fatica del corpo, l’ascesi , la custodia del cuore e l’attuazione dei comandi divini come l’ abba Agatone ricorda in un apoftegma:
Domandarono una volta ad Agatone: “Cosa vale di più, la fatica del corpo o la custodia del cuore?”. L’anziano rispose: “L’uomo è come un albero: la fatica del corpo sono le foglie, la custodia del cuore il frutto. Ora, poiché com’è scritto, Ogni albero che non produce frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco, è chiaro che tutto il nostro impegno deve tendere al frutto, cioè a custodire il nostro spirito. Ma è necessaria anche la protezione e l’ornamento delle foglie, cioè la fatica del corpo”.
Anche Teofane il Recluso, il linea con la tradizione, evidenzia l’importanza della fatica del corpo e del cuore:
Quello che cerchiamo in tutti i nostri sforzi e combattimenti ascetici è la purificazione del cuore e il ristabilimento dello spirito. Ci sono due modi di arrivarci: la via attiva, cioè la pratica di una disciplina ascetica, e la via contemplativa, che consiste nel rivolgere la mente a Dio.
Quando il peccato è reiterato allora nel cuore dell’uomo si produce un habitus che gli autori antichi chiamavano passione. Questi pensieri o, peggio, queste passioni vanno estirpate dal cuore; i primi sono più facilmente, affrontabili le seconde necessitano di un lavoro più duro, di pentimento e ascesi, come ci ricorda Doroteo di Gaza:
Fate attenzione, fratelli, a come sono le cose e guardate di non trascurare voi stessi, perché anche una piccola trascuratezza ci porta a grandi pericoli […] Si sottovalutano sempre i piccoli squilibri e non si sa che se il corpo si ammala anche un po’, specialmente se l’individuo è un po’ debole, c’è bisogno di molta fatica e tempo prima che si ristabilisca.
A sostegno di ciò, egli racconta una storia che rappresenta bene la fatica di estirpare le passioni:
Un grande Anziano stava in ricreazione con i suoi discepoli in un posto dove c’erano diversi cipressi, piccoli e grandi. L’Anziano disse a uno dei discepoli: “ Strappa questo cipresseto”. Era piccolissimo e il fratello lo strappò subito con una sola mano. Poi l’Anziano gliene mostrò un altro più grande del primo e disse: “Strappa anche questo”. Quello lo scosse con tutte e due le mani e lo strappò. Di nuovo l’Anziano gliene indicò uno più grande ancora: e lui riuscì a strappare anche quello, ma con maggior fatica. Gliene mostrò un altro ancora più grande, e dopo averlo molto scosso e aver faticato molto e sudato, sollevò anche quello. Poi l’Anziano gliene indicò uno ancora più grande e lui fatico e sudò parecchio, ma non riuscì a smuoverlo. Come l’Anziano vide che non ce la faceva, ordinò ad un altro fratello di alzarsi e di aiutarlo, e così riuscirono, tra tutti e due, a strapparlo. Allora l’Anziano disse ai fratelli: “ Ecco, fratello, così sono le passioni: fin quando sono piccole, se vogliamo, riusciamo tranquillamente a reciderle. Ma se le lasciamo stare perché sono piccole, s’induriscono, e quanto più s’induriscono, di tanto maggior fatica hanno bisogno. Se poi continuano a ingrossarsi contro di noi, nemmeno con fatica riusciamo più a tagliarle da noi stessi, se non otteniamo aiuto da qualche santo che, dopo Dio, si prenda cura di noi.
Un aspetto che caratterizza fortemente la praxis negativa è certamente la penitenza e il penthos (compunzione). La penitenza ha come elemento essenziale la capacità di riconoscere il proprio peccato di fronte a Dio, di biasimare le proprie colpe e condannare se stessi. Spesso ricorre nella letteratura monastica l’imperativo «Bada a te stesso!», o espressioni come «Fa lutto su di te» oppure «Medico, cura te stesso!», o anche «Condannare se stessi».
A titolo di esempio presentiamo alcuni passi tratti dagli Insegnamenti Spirituali di Doroteo di Gaza il quale dedica un “capitolo” intero al tema del «Biasimo di sé» che fa da contrappunto ad un tema complementare, «Non si deve giudicare il prossimo»:
A volte si disprezza colui che vuole affliggerci e non lo si considera per nulla [...]. Voglio raccontarvi un episodio che vi farà meravigliare. Nel cenobio, prima che io venissi via di là, c’era un fratello che io non vedevo mai turbato o afflitto con nessuno; eppure vedevo che molti fratelli lo maltrattavano e lo strapazzavano in vario modo [...]. Un giorno lo presi da parte [...] e lo invitai a dirmi quale pensiero aveva sempre nel suo cuore, sia che venisse maltrattato, sia che ricevesse qualsiasi sgarbo, visto che dimostrava una tale pazienza. Egli mi rispose [...] e mi disse: «Io non ho che da stare attento a queste ingiurie e accettarle da loro come i cani giovani le accettano dagli uomini». [...] L’origine di ogni turbamento, se cerchiamo con precisione, è nel fatto che non rimproveriamo noi stessi: per questo [...] non troviamo mai riposo. Non ci si deve meravigliare, infatti, se sentiamo dire dai santi che tranne questa non c’è altra strada [...]. Quale gioia, quale riposo non ha dovunque vada, come ha detto l’abba Poimen, colui che rimprovera sé stesso. Gli può accadere di ricevere danno, offesa, qualsiasi afflizione: ma già da prima se ne considera meritevole e non si turba mai.
Anche quando apparentemente sembra che non ci sia alcunché di cui rimproverarsi, Doroteo di Gaza invita i monaci ad esaminarsi scrupolosamente per trovare qualche motivo, seppur remoto, per accusarsi:
Ma si dirà: «E se il fratello mi affligge e io faccio l’esame di coscienza e trovo che non gli ho offerto alcun pretesto, come posso rimproverare me stesso? ». Veramente, se uno si esamina con timor di Dio, trova che certamente ha dato motivo o con le azioni o con le parole o con il comportamento. E se pure vede, come dice, che in nessuna di queste cose ha dato assolutamente motivo per il presente, é probabile che un’altra volta lo abbia afflitto o per la stessa cosa o per un’altra.
Il turbamento che spesso è frutto della presunzione di sé e dell’orgoglio ferito a volte può essere utilizzato a vantaggio della vita spirituale, infatti la tentazione esterna che porta al turbamento può avere il valore positivo di rivelare una passione latente di cui non si ha coscienza e può rappresentare una notevole occasione di purificazione:
Talvolta poi uno si vede ben piazzato nella pace e nella tranquillità ma quando un fratello gli dice una parola che lo rattrista, si turba e per questo crede di avere ragione ad affliggersi e dice contro di lui: «Se non veniva a parlarmi e a turbarmi, non avrei peccato». Anche questo è un’impertinenza, anche questo è un ragionamento storto. È forse colui che gli ha detto quella parola che ha messo in lui la passione? La passione era già in lui, e quello non ha fatto altro che portargliela alla luce perché, se vuole, possa pentirsene. Egli infatti è simile ad un pane di fior di farina, bello fuori ma dentro muffo: quando uno lo spezza, allora si vede il suo marciume. Così anche lui se ne stava in pace, come credeva, ma dentro aveva la passione e non lo sapeva.
Condannare, o biasimare continuamente se stessi, permette al cuore di accogliere il pentimento, la compunzione, il penthos:
Se tu condanni incessantemente te stesso, il tuo cuore sarà compunto per accogliere il pentimento.
La compunzione (πένθος) va oltre la penitenza. Essa è l’atteggiamento fondamentale del monaco; è afflizione, tristezza che deriva dall’aver offeso o contristato qualcuno che si ama, è dispiacere per la salvezza perduta. Spesso il penthos è lutto per il proprio passato peccaminoso che genera le lacrime. «Ci sono molti tipi di lacrime, ed è essenziale operare una distinzione. La differenza cruciale si pone fra le lacrime carnali e le lacrime spirituali ( c’è una terza possibilità: le lacrime possono essere demoniache). Le lacrime carnali sono emotive, quelle spirituali sono ascetiche. Le prime sono generalmente legate alle passioni: sono spesso frutto della collera, della frustrazione, dell’invidia, dell’autocommiserazione, o semplicemente dell’eccitazione nervosa. Le seconde, come suggerisce il loro nome, sono un dono della grazia divina dello Spirito santo, non semplice risultato dei nostri sforzi, e sono strettamente legate alla preghiera. Secondo i padri, le lacrime sono principalmente di due ordini. Sul piano più basso sono amare; a un livello più elevato, dolci. Su un piano inferiore sono una forma di purificazione; al livello più elevato, di illuminazione» .
La compunzione vera che provoca le lacrime irradia nel cuore del penitente una gioia particolare, una dolcezza che verifica l’autenticità della compunzione stessa; essa è dono di Dio. Dice infatti San Giovanni Climaco:
A riflettere sulla natura della vera compunzione, non so come essa, dentro il lutto e l’afflizione di cui parliamo, nasconda una gioia e una felicità paragonabile al miele dentro il favo. Che conclusione ne trarremo? Che siffatta compunzione è veramente un dono del Signore. Poiché non è possibile dolcezza spirituale senza amarezza, quando Dio nel segreto consola i contriti di cuore
Nella letteratura spirituale antica sovente viene sottolineata questa dimensione della vita ascetica: essa rappresenta un aspetto necessario che purifica il cuore del monaco e lo apre alla pratica della preghiera pura (contemplazione o theoria).
È dunque la praxis che eleva il monaco alla theoria, cioè ogni fatica, globalmente intesa, fisica, spirituale, morale, introduce l’uomo nel «regno dei cieli». Padre Špidlík propone alcune chiarificazioni di questo assioma generale della vita spirituale:
· La purificazione deve precedere l’illuminazione;
· Le virtù introducono alla conoscenza;
· La vita in Cristo conduce all’illuminazione;
· Dal visibile si giunge alla conoscenza dell’invisibile;
· L’uomo interno entra in relazione con Dio;
· La teologia del tempo e dell’eternità;
· L’unione diviene ascesi mistica;
Indipendentemente dall’interpretazione che si vuole preferire, rimane vero che l’opera del monaco è indirizzata al recupero della propria salute spirituale e all’acquisizione dell’unione con Dio, al raggiungimento di un cuore e di una mente puri e quindi della contemplazione.
Affinché l’uomo raggiunga la contemplazione e viva la preghiera pura, è necessario che la sua mente sia sgombra di ogni sorta di immagini e concetti e pensieri cattivi o di carattere spirituale, è indispensabile che essa sia pura. « La prima condizione della contemplazione è […] la purificazione dal peccato, la penitenza, perché lo Sposo non ama unirsi ad un’anima che gli è estranea».
Tutti gli autori sono concordi sulla necessità di estirpare ogni impurità dal cuore; non c’è invece concordanza su in che cosa consista concretamente questa purificazione: se sia purificazione della carne, dei sensi, dei pensieri cattivi, del peccato.
Afferma Evagrio Pontico che la preghiera non potrà essere pura se l’orante si lascia coinvolgere da faccende materiali e turbare da continue preoccupazioni. Preghiera, infatti, vuol dire rimozione dei pensieri.
Nella spiritualità monastica, generalmente il termine pensiero ha un’accezione del tutto negativa: è lo strumento attraverso il quale il nemico può entrare nel cuore dell’uomo e così indurlo al peccato. Non può pregare in maniera tranquilla colui che non ha acquisito l’arte di combattere i propri nemici spirituali.
Gli autori antichi insegnano la differenza tra «pensiero semplice» e «pensiero appassionato».
La mente umana, fatta ad immagine di quella divina, può pensare qualsiasi cosa; generalmente però quanto viene pensato è raro che risulti essere «puro», in quanto al pensiero si aggiunge la tendenza a desiderare qualcosa contro i comandi di Dio, ciò che i greci chiamano prospatheia. L’uomo spirituale dovrà distinguere il pensiero dalla sua passione. Doroteo di Gaza chiama questo pensiero passionale «volontà propria».
La tradizione monastica ha cercato di praticare questa purificazione della parte passionale dell’anima attraverso la fatica del corpo, l’ascesi , la custodia del cuore e l’attuazione dei comandi divini come l’ abba Agatone ricorda in un apoftegma:
Domandarono una volta ad Agatone: “Cosa vale di più, la fatica del corpo o la custodia del cuore?”. L’anziano rispose: “L’uomo è come un albero: la fatica del corpo sono le foglie, la custodia del cuore il frutto. Ora, poiché com’è scritto, Ogni albero che non produce frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco, è chiaro che tutto il nostro impegno deve tendere al frutto, cioè a custodire il nostro spirito. Ma è necessaria anche la protezione e l’ornamento delle foglie, cioè la fatica del corpo”.
Anche Teofane il Recluso, il linea con la tradizione, evidenzia l’importanza della fatica del corpo e del cuore:
Quello che cerchiamo in tutti i nostri sforzi e combattimenti ascetici è la purificazione del cuore e il ristabilimento dello spirito. Ci sono due modi di arrivarci: la via attiva, cioè la pratica di una disciplina ascetica, e la via contemplativa, che consiste nel rivolgere la mente a Dio.
Quando il peccato è reiterato allora nel cuore dell’uomo si produce un habitus che gli autori antichi chiamavano passione. Questi pensieri o, peggio, queste passioni vanno estirpate dal cuore; i primi sono più facilmente, affrontabili le seconde necessitano di un lavoro più duro, di pentimento e ascesi, come ci ricorda Doroteo di Gaza:
Fate attenzione, fratelli, a come sono le cose e guardate di non trascurare voi stessi, perché anche una piccola trascuratezza ci porta a grandi pericoli […] Si sottovalutano sempre i piccoli squilibri e non si sa che se il corpo si ammala anche un po’, specialmente se l’individuo è un po’ debole, c’è bisogno di molta fatica e tempo prima che si ristabilisca.
A sostegno di ciò, egli racconta una storia che rappresenta bene la fatica di estirpare le passioni:
Un grande Anziano stava in ricreazione con i suoi discepoli in un posto dove c’erano diversi cipressi, piccoli e grandi. L’Anziano disse a uno dei discepoli: “ Strappa questo cipresseto”. Era piccolissimo e il fratello lo strappò subito con una sola mano. Poi l’Anziano gliene mostrò un altro più grande del primo e disse: “Strappa anche questo”. Quello lo scosse con tutte e due le mani e lo strappò. Di nuovo l’Anziano gliene indicò uno più grande ancora: e lui riuscì a strappare anche quello, ma con maggior fatica. Gliene mostrò un altro ancora più grande, e dopo averlo molto scosso e aver faticato molto e sudato, sollevò anche quello. Poi l’Anziano gliene indicò uno ancora più grande e lui fatico e sudò parecchio, ma non riuscì a smuoverlo. Come l’Anziano vide che non ce la faceva, ordinò ad un altro fratello di alzarsi e di aiutarlo, e così riuscirono, tra tutti e due, a strapparlo. Allora l’Anziano disse ai fratelli: “ Ecco, fratello, così sono le passioni: fin quando sono piccole, se vogliamo, riusciamo tranquillamente a reciderle. Ma se le lasciamo stare perché sono piccole, s’induriscono, e quanto più s’induriscono, di tanto maggior fatica hanno bisogno. Se poi continuano a ingrossarsi contro di noi, nemmeno con fatica riusciamo più a tagliarle da noi stessi, se non otteniamo aiuto da qualche santo che, dopo Dio, si prenda cura di noi.
Un aspetto che caratterizza fortemente la praxis negativa è certamente la penitenza e il penthos (compunzione). La penitenza ha come elemento essenziale la capacità di riconoscere il proprio peccato di fronte a Dio, di biasimare le proprie colpe e condannare se stessi. Spesso ricorre nella letteratura monastica l’imperativo «Bada a te stesso!», o espressioni come «Fa lutto su di te» oppure «Medico, cura te stesso!», o anche «Condannare se stessi».
A titolo di esempio presentiamo alcuni passi tratti dagli Insegnamenti Spirituali di Doroteo di Gaza il quale dedica un “capitolo” intero al tema del «Biasimo di sé» che fa da contrappunto ad un tema complementare, «Non si deve giudicare il prossimo»:
A volte si disprezza colui che vuole affliggerci e non lo si considera per nulla [...]. Voglio raccontarvi un episodio che vi farà meravigliare. Nel cenobio, prima che io venissi via di là, c’era un fratello che io non vedevo mai turbato o afflitto con nessuno; eppure vedevo che molti fratelli lo maltrattavano e lo strapazzavano in vario modo [...]. Un giorno lo presi da parte [...] e lo invitai a dirmi quale pensiero aveva sempre nel suo cuore, sia che venisse maltrattato, sia che ricevesse qualsiasi sgarbo, visto che dimostrava una tale pazienza. Egli mi rispose [...] e mi disse: «Io non ho che da stare attento a queste ingiurie e accettarle da loro come i cani giovani le accettano dagli uomini». [...] L’origine di ogni turbamento, se cerchiamo con precisione, è nel fatto che non rimproveriamo noi stessi: per questo [...] non troviamo mai riposo. Non ci si deve meravigliare, infatti, se sentiamo dire dai santi che tranne questa non c’è altra strada [...]. Quale gioia, quale riposo non ha dovunque vada, come ha detto l’abba Poimen, colui che rimprovera sé stesso. Gli può accadere di ricevere danno, offesa, qualsiasi afflizione: ma già da prima se ne considera meritevole e non si turba mai.
Anche quando apparentemente sembra che non ci sia alcunché di cui rimproverarsi, Doroteo di Gaza invita i monaci ad esaminarsi scrupolosamente per trovare qualche motivo, seppur remoto, per accusarsi:
Ma si dirà: «E se il fratello mi affligge e io faccio l’esame di coscienza e trovo che non gli ho offerto alcun pretesto, come posso rimproverare me stesso? ». Veramente, se uno si esamina con timor di Dio, trova che certamente ha dato motivo o con le azioni o con le parole o con il comportamento. E se pure vede, come dice, che in nessuna di queste cose ha dato assolutamente motivo per il presente, é probabile che un’altra volta lo abbia afflitto o per la stessa cosa o per un’altra.
Il turbamento che spesso è frutto della presunzione di sé e dell’orgoglio ferito a volte può essere utilizzato a vantaggio della vita spirituale, infatti la tentazione esterna che porta al turbamento può avere il valore positivo di rivelare una passione latente di cui non si ha coscienza e può rappresentare una notevole occasione di purificazione:
Talvolta poi uno si vede ben piazzato nella pace e nella tranquillità ma quando un fratello gli dice una parola che lo rattrista, si turba e per questo crede di avere ragione ad affliggersi e dice contro di lui: «Se non veniva a parlarmi e a turbarmi, non avrei peccato». Anche questo è un’impertinenza, anche questo è un ragionamento storto. È forse colui che gli ha detto quella parola che ha messo in lui la passione? La passione era già in lui, e quello non ha fatto altro che portargliela alla luce perché, se vuole, possa pentirsene. Egli infatti è simile ad un pane di fior di farina, bello fuori ma dentro muffo: quando uno lo spezza, allora si vede il suo marciume. Così anche lui se ne stava in pace, come credeva, ma dentro aveva la passione e non lo sapeva.
Condannare, o biasimare continuamente se stessi, permette al cuore di accogliere il pentimento, la compunzione, il penthos:
Se tu condanni incessantemente te stesso, il tuo cuore sarà compunto per accogliere il pentimento.
La compunzione (πένθος) va oltre la penitenza. Essa è l’atteggiamento fondamentale del monaco; è afflizione, tristezza che deriva dall’aver offeso o contristato qualcuno che si ama, è dispiacere per la salvezza perduta. Spesso il penthos è lutto per il proprio passato peccaminoso che genera le lacrime. «Ci sono molti tipi di lacrime, ed è essenziale operare una distinzione. La differenza cruciale si pone fra le lacrime carnali e le lacrime spirituali ( c’è una terza possibilità: le lacrime possono essere demoniache). Le lacrime carnali sono emotive, quelle spirituali sono ascetiche. Le prime sono generalmente legate alle passioni: sono spesso frutto della collera, della frustrazione, dell’invidia, dell’autocommiserazione, o semplicemente dell’eccitazione nervosa. Le seconde, come suggerisce il loro nome, sono un dono della grazia divina dello Spirito santo, non semplice risultato dei nostri sforzi, e sono strettamente legate alla preghiera. Secondo i padri, le lacrime sono principalmente di due ordini. Sul piano più basso sono amare; a un livello più elevato, dolci. Su un piano inferiore sono una forma di purificazione; al livello più elevato, di illuminazione» .
La compunzione vera che provoca le lacrime irradia nel cuore del penitente una gioia particolare, una dolcezza che verifica l’autenticità della compunzione stessa; essa è dono di Dio. Dice infatti San Giovanni Climaco:
A riflettere sulla natura della vera compunzione, non so come essa, dentro il lutto e l’afflizione di cui parliamo, nasconda una gioia e una felicità paragonabile al miele dentro il favo. Che conclusione ne trarremo? Che siffatta compunzione è veramente un dono del Signore. Poiché non è possibile dolcezza spirituale senza amarezza, quando Dio nel segreto consola i contriti di cuore










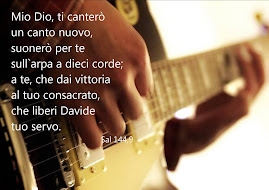
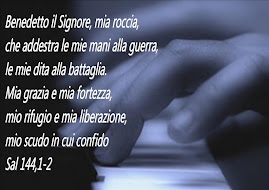















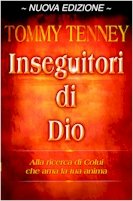





Nessun commento:
Posta un commento